La prima lettura, di domenica, viene sempre dall’Antico Testamento ed è direttamente collegata al tema del Vangelo. Nella liturgia feriale invece avviene il contrario: la prima lettura può essere del Nuovo o dell’Antico Testamento perché si legge un libro in modo continuato e il Vangelo è scelto in riferimento
ad esso.
Segue il salmo detto “responsoriale” perché non si tratta più di ascoltare soltanto ma siamo già chiamati a dire anche noi qualcosa perché è fondamentale fare nostre le parole che ascoltiamo, capirle e ripeterle per vedere se abbiamo capito, un po’ come quando si studia. Il rito del salmo responsoriale è proprio, come diceva san Filippo, un “parlare la parola di Dio”. Peraltro, la ripetizione di un ritornello non è l’unica forma possibile per pregarlo, lo stesso ritornello proposto potrebbe essere usato come antifona all’inizio e alla fine oppure può essere ripetuto più volte e anche cambiato.
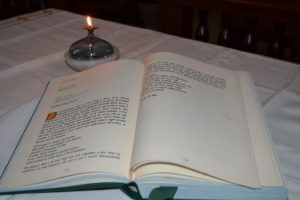 La domenica c’è anche una seconda lettura che è presa da una lettera di un apostolo. Questa lettura ci fa entrare in quella dimensione comunitaria di cui si è parlato sopra. Quando ascoltiamo la Parola di Dio lo facciamo in modo personale perché ciò che dice lo dice a me e non a quello del primo banco, ma non è un modo singolare e autonomo, c’è sempre una comunità che media questa Parola. Le lettere erano proprio il modo degli apostoli per mantenere la comunione con le comunità che avevano fondato. Risentire queste parole ci fa sentire più Chiesa. La seconda lettura è spesso sganciata dal tema delle altre due perché viene letta in modo continuato una lettera.
La domenica c’è anche una seconda lettura che è presa da una lettera di un apostolo. Questa lettura ci fa entrare in quella dimensione comunitaria di cui si è parlato sopra. Quando ascoltiamo la Parola di Dio lo facciamo in modo personale perché ciò che dice lo dice a me e non a quello del primo banco, ma non è un modo singolare e autonomo, c’è sempre una comunità che media questa Parola. Le lettere erano proprio il modo degli apostoli per mantenere la comunione con le comunità che avevano fondato. Risentire queste parole ci fa sentire più Chiesa. La seconda lettura è spesso sganciata dal tema delle altre due perché viene letta in modo continuato una lettera.Segue il canto al Vangelo. “Alleluia” è il canto di Pasqua, della risurrezione e ci aiuta a vedere quella che andiamo ad ascoltare come una parola viva perché la parola del risorto. Egli è vivo, non come quelli che aveva risuscitati e che sono morti di nuovo. Gesù è risorto una volta per sempre ed è sempre vivo e operante e lo incontriamo soprattutto nella sua Chiesa. È un canto, si chiama appunto “canto al Vangelo”. In Quaresima al posto dell’Alleluia si esegue un altro canto al Vangelo per sentire la privazione dello sposo di cui Gesù stesso parla nel Vangelo a proposito del digiuno e sentire tutto il desiderio di esplodere finalmente nel suo canto a Pasqua. Tuttavia, questa espressione quaresimale ha lo stesso significato.
Anche il Vangelo si legge in modo continuato: ogni anno viene letto uno dei tre vangeli sinottici più o meno completamente. Vangelo significa letteralmente “buon messaggio”: qual è questo messaggio che ci viene rivolto? Gesù stesso. Quando egli parla, parla di sé stesso perché quando viene è il Regno di Dio già presente in mezzo a noi: incontrando e ascoltando Gesù ci siamo già dentro con un piede. Importantissimo è il segno di croce, detto “minore”, che si fa mentre diciamo la risposta “Gloria a te, o Signore”. Sono tre segni di croce tracciati con il pollice sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. Questo segno di croce è molto più antico rispetto a quello che facciamo su tutto il corpo; lo troviamo addirittura nella Scrittura: c’è già nel libro del profeta Ezechiele e nell’Apocalisse dove compare il comando di segnare gli eletti con un “tau”, la lettera greca scritta come una croce. Il senso è che quella parola viva ci entri in testa: anzitutto perché se non entra fisicamente attraverso le orecchie siamo già fermi ma soprattutto perché vi entri come rinnovamento della mentalità.
Poi che sia sulla bocca: il nostro parlare è stato consacrato perché Dio si è rivelato prima attraverso parole umane e poi attraverso la sua Parola definitiva incarnata; la consacrazione della bocca attraverso questo segno è anche l’impegno che ci assumiamo di andare a dirla agli altri. Infine, che l’ascolto non sia solo con la testa ma soprattutto col cuore. Cor ad cor loquitur: il cuore di Dio che è Gesù vuole parlare al nostro cuore e con questo piccolo segno lo rendiamo disponibile ad ascoltarlo.
A cura del Gruppo Liturgico Parrocchia Gesù Risorto
Please follow and like us:


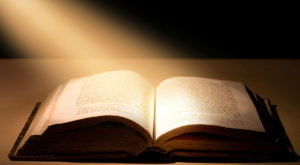






Commenti recenti